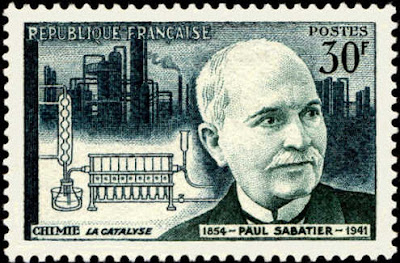QUI, Chiusoli e altri autori approfondiscono il ruolo dello ione ioduro (I-) in alcuni cicli catalitici di reazioni di interesse pratico e speculativo.
Le proprietà uniche dell'anione ioduro gli consentono di essere coinvolto in molti modi diversi nelle reazioni catalizzate dai metalli di late-transition: nell'addizione ossidativa, nella migrazione e nelle fasi di accoppiamento /eliminazione riduttiva, nonché nell'attivazione del substrato.
La maggior parte dei passaggi sono accelerati da I- (ad esempio attraverso una maggiore nucleofilicità del centro metallico), ma alcuni sono ritardati, perché un sito di coordinazione è bloccato.
Lo ioduro soft si lega più fortemente ai metalli soft (nei quali il centro metallico è in basso stato di ossidazione, ricco di elettroni e polarizzabile) come i metalli di transizione più pesanti, rispetto agli altri alogenuri, o ai leganti N e O - donatori.
Quindi in un ciclo catalitico che include il metallo in uno stato di ossidazione formalmente basso ci sarà meno tendenza per il metallo a precipitare (ed essere rimosso dal ciclo) in presenza di I- rispetto alla maggior parte degli altri leganti.
Lo ioduro è un buon nucleofilo ed è anche facilmente e reversibilmente ossidato a iodio elementare. Inoltre, atomi di iodio possono svolgere ruoli chiave nelle reazioni puramente organiche che si verificano come parte di un ciclo catalitico. Quindi per comprendere la funzione dello ioduro è necessaria un'analisi attenta, poiché due o talvolta più effetti si verificano in fasi diverse di un singolo ciclo.
Nell'articolo, ciascuno di questi argomenti è illustrato con esempi dell'influenza dello ioduro da reazioni catalitiche omogenee in letteratura: carbonilazione del metanolo ad acido acetico e reazioni correlate; idrogenazione del CO; idrogenazione dell'immina; reazioni di coupling. Le caratteristiche generali sono riassunte nelle conclusioni.