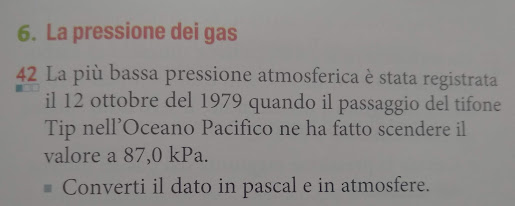Scrivendo la data di oggi alla lavagna, affinché i miei discepoli la riportassero correttamente sul compito, mi sono accorto di un accostamento familiare: 6... 10... 23... eccolo di seguito.
Più precisamente, dovrei scrivere 6.022 per dieci alla ventitreesima: è il valore del numero di Avogadro, ossia del numero di particelle contenute in una mole di una sostanza pura:
- di atomi, se si tratta di un elemento;
- di molecole, se si tratta di un composto;
- di ioni, se si tratta di un cristallo.
Il valore del numero di Avogadro non fu trovato da Avogadro, ma da Jean Baptiste Perrin (1870-1942) molti anni dopo la sua morte. Anche il moderno concetto di mole non è di Avogadro, ma di Wilhelm Ostwald (1853-1932), chimico tedesco di cui mi sono interessato per altri motivi, come potete leggere QUI.
E allora chiediamoci: quali sono i meriti di Avogadro se ha potuto meritare che una delle più importanti costanti della fisica e della chimica porti il suo nome?
Amedeo Avogadro (1776-1856), conte di Quaregna e di Cerreto, fu uno studente molto brillante; si laureò in legge, con una tesi in diritto canonico, per dedicarsi all'avvocatura. Si appassionò per diletto agli studi scientifici, divenne professore di matematica e di fisica al liceo di Vercelli e socio dell'Accademia delle Scienze di Torino.
Durante gli anni vercellesi, Avogadro enunciò il principio conosciuto con il suo nome, riportato anche nel francobollo commemorativo emesso da Poste Italiane nel centenario della morte:
Tale principio è fondamentale nella storia della teoria atomico-molecolare della materia; fu pubblicato nel 1811 e dapprima ignorato dalla comunità scientifica, nonostante Ampere giunse a conclusioni simili negli stessi anni.
Forse le sue idee politiche progressiste, per le quali fu allontanato dall'insegnamento e dai salotti buoni avendo partecipato ai moti del 1821 contro il re di Sardegna, gli costarono la diffusione delle sue idee scientifiche. Ritornò all'insegnamento della fisica nel 1833 per lasciarlo nel 1850: non più a Vercelli, ma all'università di Torino.
Intanto, i lavori sperimentali in chimica organica (ad opera di Gerhardt, Laurent, Williamson) e i lavori sulla teoria cinetica dei gas di Clausius confermarono ripetutamente la validità del principio di Avogadro.
Così scrisse Stanislao Cannizzaro (1826-1910), all'inizio del suo Sunto di un corso di filosofia chimica, distribuito al primo congresso internazionale di chimica a Karlsruhe nel 1860:
Io credo che i progressi della scienza, fatti in questi ultimi anni, abbiano confermato l’ipotesi di Avogadro, di Ampère e di Dumas sulla simile costituzione dei corpi allo stato aeriforme, cioè che i volumi eguali di essi, sieno semplici, sieno composti, contengono l’egual numero di molecole; non però l’egual numero di atomi, potendo le molecole dei varii corpi o quelle dello stesso corpo nei varii suoi stati, contenere un vario numero di atomi, sia della medesima natura, sia di natura diversa.
Per condurre i miei allievi al medesimo convincimento che io ho, gli ho voluto porre sulla medesima strada per la quale io ci son giunto, cioè per l’esame storico delle teorie chimiche.
Incominciai dunque nella prima lezione a dimostrare come dall’esame delle proprietà fisiche dei corpi aeriformi e dalla legge di Gay Lussac, sui rapporti di volume tra i componenti ed i composti, scaturì quasi spontanea l’ipotesi sopra ricordata, che fu la prima volta annunziata d’Avogadro e poco dopo d’Ampère.
A questo punto, ritengo non sia necessario aggiungere altro sul perché Avogadro abbia meritato di dare il nome al numero il cui valore quasi mai è ricordato dagli scolari, nemmeno guardando la data scritta sulla lavagna.