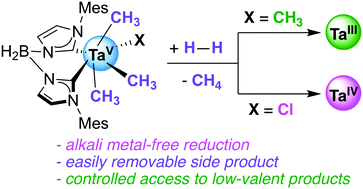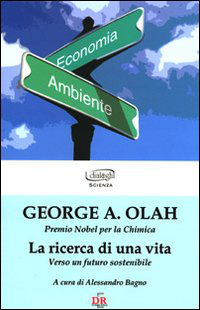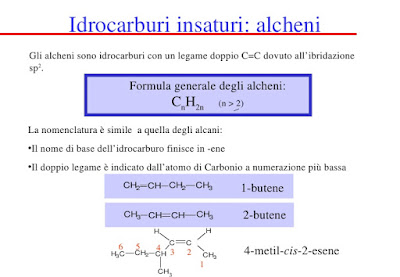Vladimir Haensel fu l’ingegnere
chimico americano al quale è dovuta l’invenzione del processo di Platforming –
che migliora la qualità della benzina, ottenuta dal petrolio greggio per
distillazione primaria.
LA VITA. Nato a Friburgo (Germania) il 1°
settembre 1914, trascorse infanzia e giovinezza a Mosca, dove suo padre, Paul
Haensel, era professore di economia. Si trasferì negli USA nel 1930.
Conseguì il baccellierato alla
Northwestern University e la laurea al MIT nel 1937, ottenendo un posto di
lavoro alla UOP (Universal Oil Products company) nello stesso anno. Continuò
comunque gli studi e concluse il dottorato nel 1941 alla Northwestern
University nel 1941.
Durante la Seconda Guerra
Mondiale, fu in Europa per documentarsi sui progressi della chimica tedesca
intorno allo sviluppo dei carburanti sintetici.
Fece carriera in UOP nel settore
ricerca e sviluppo; nel 1980 divenne docente di ingegneria chimica
all’Università del Massachusetts, ove rimase fino alla morte avvenuta il 15
dicembre 2002.
Egli si interessò di superfici
catalitiche, brevettando diversi metodi per migliorare i processi chimici
nell’industria petrolifera e dando un contributo notevole allo sviluppo del
convertitore catalitico per automobili.
GLI ANTEFATTI. Per migliorare la qualità della
benzina primaria, già negli anni Trenta si procedeva con un Reforming termico, condotto a elevate temperature (600°C) e
pressioni: questo favoriva tuttavia la formazione di olefine, idrogeno e soprattutto
coke.
Benzine di alta qualità,
destinate all’aviazione militare, erano state nel frattempo ottenute sempre nei
laboratori UOP da Bloch, Pines e Ipatiev attraverso l’alchilazione di frazioni
gassose (a 3 o 4 atomi di carbonio) a dare ottani ramificati (a 7 o 8 atomi di
carbonio): la reazione era catalizzata da acidi. Prima fu usato l’ac.
solforico, poi sostituito dall’ac. fluoridrico. Pines sottolineò poi come anche questo carburante permise agli aerei della RAF di vincere la battaglia
d’Inghilterra (10 luglio – 31 ottobre 1940), giocando sulla aumentata velocità dei
velivoli alleati rispetto a quelli tedeschi.
Durante la Seconda Guerra
Mondiale, il metilcicloesano era convertito in toluene su catalizzatori a base
di ossidi di molibdeno e alluminio – che però favorivano anche la formazione di coke.
IL PLATINO. Scoperto da Antonio
De Ulloa a metà del Settecento, il platino era noto ai chimici per le sue proprietà
catalitiche fin dagli inizi del XIX secolo. Dall’accendino di Dobereiner alla decomposizione
dell’acqua ossigenata (reazione per la quale Berzelius introdusse il termine catalisi), dall’ossidazione di SO2
di Knietsch a quella dell’ammoniaca di Ostwald: alcune reazioni favorite da
questo metallo erano note e descritte.
Il platino era troppo costoso per
essere impiegato tal quale nell’industria petrolifera: Haensel dimostrò che
producendo un supporto ceramico sul quale era dispersa in superficie una
piccola quantità di metallo, era possibile sfruttare comunque le sue qualità
catalitiche.
L’azione del platino, combinata
con le proprietà acide dell’allumina (attivata con cloruro), favoriva l’incremento della qualità dei
carburanti (in particolare del potere antidetonante, espresso in termini di numero di ottano) grazie a:
- isomerizzazione
delle catene lineari (benzina normale) a ramificate (benzina super)
- deidrociclizzazione degli idrocarburi lineari a cicloalcani e deidrogenazione
dei cicloalcani ad aromatici. Al contempo si otteneva idrogeno, necessario per
rimuovere zolfo, azoto, ossigeno ma responsabile anche di indesiderate reazioni
di hydrocracking (che portano alla formazione di prodotti leggeri: metano,
etano, propano, butano).
LE TECNOLOGIE. Il primo impianto entrò in
funzione nel 1949 nella raffineria di Muskegon, in Michigan: tuttavia si notò
che il catalizzatore (circa un chilo di platino distribuito in 4,5 tonnellate di
allumina) era soggetto ad avvelenamento da parte di composti azotati,
solforati, arsenico e metalli – pertanto era necessario pretrattare la carica
con idrogeno e opportuni catalizzatori per eliminare i veleni.
Un progresso fondamentale fu
stato segnato dall’introduzione di un catalizzatore bimetallico a base di
platino e renio (che limita l’attività del platino): il processo fu sviluppato
nei laboratori della Chevron e prese il nome di Rheniforming.
Seguirono il Powerforming della
ESSO, il Magnaforming e il Catforming dell’Atlantic, l’Ultraforming della
British Petroleum, l’Houdriforming, il Sovaforming della Socony Vacuum, il
Premiumforming della Snam Progetti e il processo Octanizing – Axens dell’IFP.
La rapida diffusione del processo
è dovuta al fatto che esso produce al contempo benzina di alta qualità, idrogeno e idrocarburi aromatici (BTX).
L’idrogeno è separato subito
dalla miscela dei prodotti di reazione e usato in raffineria; la benzina è
separata dai BTX per distillazione estrattiva e poi è stabilizzata; i BTX sono frazionati
a parte e destinati alla petrolchimica.